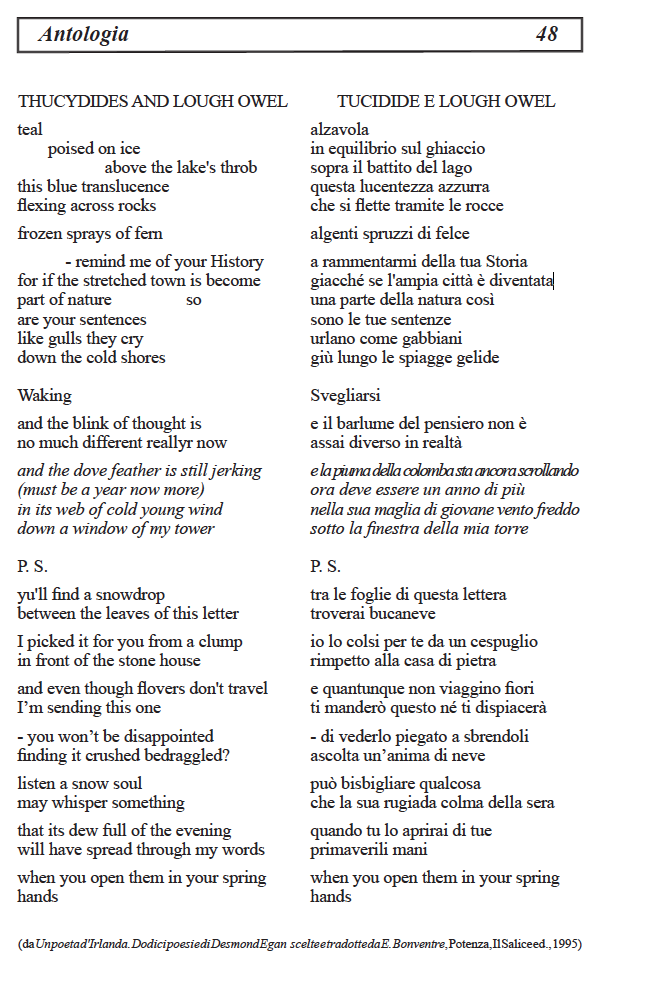A distanza di trent’anni da un mio scritto su Calogero Messina (Calogero Messina, scrittore delle attitudini umane, «Spiragli», A. I, n. 3, 1989), torno ad occuparmi di lui per esprimergli l’apprezzamento per il volume Sicilia 1492-1799. Un campionario delle crudeltà umane. Con un discorso sulla storia. Una nota di Cristina Barozzi, edito da L’Orma, Palermo 2022.
Calogero Messina, lontano – come sempre è stato – dai fracassi del nostro tempo, è uno scrittore che preferisce interrogare i tempi passati per scoprirsi e riscoprirsi ancor più autore moderno, molto attento e scrupoloso. E andando, appunto, a quel mio scritto, confermo ancor più quanto scrivevo, definendolo scrittore delle attitudini umane.
In quel saggio (si può anche leggere nel sito www.rivistaspiragli.it) fui tra i primi a presentare l’uomo e lo scrittore ad un pubblico più vasto, cogliendo già nel Messina la caratteristica di fondo della sua ricerca tesa ad evidenziare l’uomo o, meglio, ad estrapolare dai fatti l’uomo e il mondo entro cui tuttora vive ed opera; sicché, a differenza di tanti storici che si fermano a riportare la facciata, cioè, fatti e dati che nel tempo si susseguono, egli dà risalto ai fattori che con i loro pregi e difetti li caratterizzano. Ed è ciò che maggiormente conta, se si vuole conoscere la realtà in cui da sempre l’uomo si è mosso e si muove.
Questo approccio che caratterizza la ricerca di Messina si nota già negli scritti di carattere municipale e rivolti verso le piccole comunità, e fin dall’inizio della sua carriera di ricercatore si è distinto per i contributi dati in questo campo. Ricordiamo: S. Stefano Quisquina. Studio storico-critico (Palermo 1972); Il contributo di Ignazio Scaturro alla storiografia municipale: oltre l’erudizione, pubblicato in «Archivio Storico Siciliano», 1982; la riedizione di Sulla Città e Comarca di Castronuovo di Sicilia di Luigi Tirrito, a cura e con un saggio introduttivo e aggiornamento di C. Messina (Palermo 1983).
Ma non si è fermato qui, perché, oltre ad altri scritti, sulla scia di Vito Amico, a lui si deve una monumentale opera (sono in fase di pubblicazione i volumi quinto, sesto e il settimo ed ultimo volume), dove mette in risalto in maniera più capillare e metodica quanto scritto sopra; si tratta del Dizionario storico dei comuni di Sicilia, nella cui introduzione il Nostro, a proposito delle dominazioni straniere in Sicilia, scrive:
«[…] quello che interessava ai siciliani non era da dove venissero i dominatori; li giudicavano dalla misura in cui rispettavano o contrastavano il loro modo di vivere, le loro abitudini, i loro personali interessi, quello che più loro importava; per salvaguardare i loro interessi, non esitarono ad invocare il cambiamento, a sollecitare nuove conquiste» (Il mio dialogo con il can. De Gregorio, Palermo- Paris 2014, p. 139).
***
Nato a S. Stefano Quisquina, dopo la scuola media, la sua famiglia si trasferì a Palermo, perché Calogero potesse continuare gli studi verso cui era portato. Ricorderà questo particolare, insieme con altri dei suoi primi anni con tanta nostalgia (l’amore per i suoi e, in particolare, la dedizione per il padre), nelle pagine di prosa e poesia tra le più belle e riuscite di tutta la sua produzione letteraria e poetica, ricche di pathos e di dedizione al luogo natio e ai suoi, del libro Emigrati a Palermo del 2009. Qui, insieme con i ricordi, scrive dei suoi interessi culturali, della sua attività e degli incontri con gente comune, umile, che tanto gli dava in fatto di conoscenza e svolgimenti di fatti esituazioni del suo paese, ma anche con personalità del mondo letterario isolano e con religiosi, come quello particolare con il Canonico Mons. Domenico De Gregorio, con il Card. De Giorgi in occasione di un suo discorso o quello con l’arciprete Mons. Antonino Massaro, ricordato poi in Il mio amico l’Arciprete (Palermo 2017).
Dopo avere frequentato il liceo e conseguita la maturità, Calogero s’iscrisse alla facoltà di lettere classiche di quella Università, allievo di Giusto Monaco e del grecista Bruno Lavagnini che lo volle premiare con un viaggio in Grecia. Conseguì la laurea con una tesi su Calpurnio Siculo, studio pubblicato e molto apprezzato da filologi di fama internazionale, come Pierre Grimal, Raul Verdière e altri. Ma già, da studente, insieme con Calogero Cangelosi, aveva pubblicato il suo primo libro, l’antologia Motivi del nostro tempo (1968), mentre un’altra, Voci di Sicilia, la pubblicò nel 1973. Ma, a questo punto, cedo la parola all’editore di altri tempi, nonché scrittore, poeta e abile traduttore dal portoghese, il compianto Renzo Mazzone, che in una Nota, pubblicata come postfazione nella silloge Una luce nella notte. Con musiche di Filippo Messina (2010), ricorda quell’incontro.
«… Messina, promettente studente universitario, mi portò le sue poesie per l’antologia Motivi del nostro tempo (1968), il suo primo libro. Erano gli anni della contestazione, li ha ricordati l’amico Salvatore Vecchio, rievocando in particolare il suo antico rapporto con il nostro autore: “Sono ormai lontani gli anni caldi del ’68, quando negli androni della sede centrale dell’Ateneo palermitano parlavamo di poesia e di poeti, di progetti e di iniziative che ci avrebbero visti costantemente impegnati”. E mentre, continua Vecchio, “amici e colleghi, come un gregge di sbandati (nel frattempo la Facoltà di Lettere era stata trasferita nell’attuale cittadella universitaria), vivevano quei giorni del ’68 palermitano girovagando e discutendo per i corridoi”, un gruppo di giovani che avevano qualcosa in comune – il nostro Messina, Calogero Cangelosi, lo stesso Vecchio e altri “studiava la possibilità di pubblicare un libro, Motivi del nostro tempo»(Calogero Messina scrittore delle attitudini umane, in “Spiragli”, luglio- settembre 1989).
Il Nostro insegnò per qualche anno latino e greco al liceo, ma Virgilio Titone, che molto aveva apprezzato lo studio S. Stefano Quisquina (1972), lo volle con sé nell’Istituto di Storia Moderna. Il Messina da quel momento divenne l’amico e il prediletto del Maestro che lo avviò ancor più sulla strada della storia, senza peraltro distoglierlo dalla sua passione per la letteratura e la poesia. Ed è quello che lui ha fatto e continua a fare, rivelandosi ora filologo, etnologo, agiografo, ora viaggiatore instancabile e diarista alla pari dei viaggiatori moderni, ma in queste sue sfaccettature affiora sempre lo storico e il ricercatore attento che dà risalto all’umano che è in noi, a quello di ieri come di oggi, facendo emergere sempre lo scrittore e il poeta, perché nelle opere del Nostro lo scrittore e il poeta vanno di pari passo e di ciò che ostico riesce nella narrazione, se ne fa carico la poesia, più adatta, perché (avremo modo di specificarlo ancora) sa meglio esprimere l’universale.
Delle raccolte di poesia ricordiamo: Iuveniliter e Noviter, entrambe pubblicate ad Amsterdam nel 2003; Sodalitas (Palermo 1999); Au revoir Paris, con traduzione francese di Evelyne Hubert (Paris 2007); Una luce nella notte (2010). Ma il lettore del nostro poeta troverà poesie nelle altre sue opere, siano esse di storia o di racconti. Si legga, ad es., il già menzionato Emigrati a Palermo (Palermo 2009), dove alle esperienze di vita e al ricordo del padre dedica versi di forte pregnanza affettiva e di dedizione che parlano al cuore e si fissano nella mente, come “luce” che continua ad illuminare la “notte” dell’esistenza, volendo parafrasare Una luce nella notte, cit. Perché tutta la poesia di Calogero Messina è una poesia parlata: tu senti la cadenza, e ti tocca e ti lascia un segno profondo e duraturo. Non c’è in questo libro, come potrebbe sembrare a primo acchito, alcuna variazione di tema, è tutt’un poema rivolto al padre morto, a cui era molto legato e con cui continua a colloquiare, nonostante il decesso e il tempo che scorre, entrambi inesorabili; e i componimenti che danno vita a questo poema sono di una liricità che scuote il lettore e lo fa rientrare in sé e riflettere. Si legga, ad es., Il mio lamento, che è un poemetto, dove il poeta, ricordando nella prima parte i sofferenti e quanti sono impediti a vivere nella normalità («Ma ditelo a chi da troppo tempo / è buttato nel fondo di un letto / e non riesce più a staccarsi da esso / e sa che non potrà mai guarire. / Ditelo ad una povera vedova / abbandonata dai propri figli / quando più aveva bisogno di loro; / in loro aveva tutto riposto / e ora non trova il senso del suo vivere, / le sarebbe bastato vederli»), sconfessa chi afferma che la vita è bella, mentre nella seconda parte in modo più specifico rivolge il pensiero al padre ed è immerso nei ricordi che glielo portano davanti nei luoghi spesso frequentati.
Con lui al mio fianco
mi piaceva tornare ai nostri monti
e sostare a cogliere le verdure
a ricercare gli asparagi scontrosi;
non riesco ora a riguardare i luoghi
rimasti nella mia mente impressi
mi dicono molto di lui.
Lo vedo dovunque io sono
e la sua voce ritrovo se parlo
le tracce del suo volto nel mio,
[…]
Comporta la morte la vita
è sempre l’attesa del suo finire
e chi può essere felice
sapendo che finirà?
e nulla resterà nelle sue mani
e tutto ricoprà l’oblio
per sempre.
Grande è lo sconforto del poeta che sulla scia dei classici dà una lezione di vita veritiera e umana, tanto umana da scuoterci e farci pensare, perché tutto cambia. Cambiano persino i colori del mandorlo in fiore che per il poeta ormai non sono più quelli di una volta («A me ora tessono un velo nero / quei fiori bianchi e rosati / e di esso si ricopre tutta la valle») e cambia la vita dell’uomo, specie quando viene a mancare per sempre un proprio caro.
I ricordi che ci portiamo dietro sono una caratteristica della poesia del Messina, così come della sua prosa. Si leggano, ad es., i racconti di Il mandorlo in fiore (1993), che riporta anche alcuni resoconti di viaggi, o di La casa di mio nonno Calogero (2016), che prende titolo dal racconto omonimo e preannuncia il contenuto degli altri, dove emergono uomini di altro tempo dediti al lavoro, alla famiglia, al rispetto reciproco. Il libro è tutt’un pullulare di ricordi, un’immagine della Sicilia e di figure ormai scomparse ma che continuano a vivere grazie alla penna dell’autore. Il vecchietto che ammira il lavoro delle formiche, e lo paragona a quello degli uomini con tanto di differenza, o la figura del Panepinto, rimangono impresse nel cuore e nella mente dei lettori. Il tutto a conferma di quanto scrive sulla poesia: «Se volete conoscere l’animo di un uomo, non cercatela nei suoi gesti, nelle sue azioni, ma nelle sue espressioni sincere, nella sua poesia» (Sodalitas, cit., p. 111), che è la ripresa di un discorso aperto nel 1973, quando pubblicò Poesia e critica, a cui rimandiamo.
Per conoscere ancora meglio l’uomo e lo scrittore Messina, è interessante il saggio di Vittorio Riera, Calogero Messina e il Can. Domenico De Gregorio. Progetto uomo (Palermo 2017). Ma chi volesse conoscere altre notizie, critiche o eventi in cui il Nostro fu protagonista, rimandiamo al volume Calogero Messina e le sue opere. Notizie, opinioni, immagini 1968-2018, a cura di M. Madeleine e C. Barozzi (Paris 2018).
***
Il periodo storico preso in considerazione in Sicilia 1492-1799 è stato altre volte oggetto di ricerche e di studio di Calogero Messina. A testimoniarlo sono tanti altri suoi scritti storico-letterari, perché – come è stato altre volte scritto – il nostro autore è uno scrittore e poeta che ha un particolare interesse per la storia, tema principe fra i tanti trattati. Al 1986 risale il già ricordato Sicilia e Spagna nel Settecento, con prefazione di M. Ganci, ma ancora prima, nel 1980, aveva pubblicato il saggio Settecento italiano classicista e illuminista, sconfessando tanti studiosi che si erano interessati dell’argomento e che continuavano ad inquadrare e separare i classicisti dagli illuministi, dimostrando il Messina che si poteva essere classicisti e illuministi nello stesso tempo, come si evince dagli autori che studia e riporta. A questi va aggiunto il saggio I viceconsoli di Francia in Sicilia del 2001 più sotto menzionato.
Messina ha dietro di sé una vita di ricerche in biblioteche e archivi di mezza Europa, visitata in lungo e in largo, e se dice o afferma qualcosa, lo fa con competenza e cognizione di causa, perché – come scriviamo in quel saggio del 1989 – nei suoi viaggi «ricerca soprattutto la società, l’uomo: non dimentica mai la sua Sicilia, che non ritrova solo negli archivi ma soprattutto nella nostalgia, dal confronto con altre terre». Il nostro storico, forte di tutto questo lavoro di ricerca, a ragion veduta, può, in Sicilia 1492-1799, parlare di campionario delle crudeltà umane, screditando tanti storici. Interessante e ben costruito è il Discorso sulla storia, riportato alla fine dell’opera. Egli tiene a sottolineare che non si può fare storia senza tenere conto dell’uomo, che ne è l’artefice e il protagonista. Coloro che ne fanno a meno, più che storici, sono compilatori di dati e fatti che dicono poco o niente.
Quest’asserzione del Messina non è nuova, perché costituisce la base non solo del suo fare storia ma dell’essere uomo e poeta qual è. La si ritrova in un suo scritto, L’Orma, di inizio carriera che, più che un manifesto, è un programma di vita allora intrapreso e da cui non si è mai allontanato. Proprio ne L’Orma. Manifesto letterario, pubblicato nel 1976 da Thule dello scrittore e poeta Tommaso Romano, scrive: «L’uomo vivente appartiene al passato tanto quanto al presente e al futuro. Ogni uomo che ragiona non si pente del suo passato e lo trova utile allo stesso suo essere, alla sua rigenerazione, e si commuove al ricordo. Ogni uomo deve anche guardare al passato dei suoi padri e non nascondere, come oggi si usa, la commozione che ancora desta una pagina della loro vita di uomini, che è poi la vita degli uomini di sempre».
Nel Discorso sulla storia lo storico ribadisce tutto ciò, scrive che la storia sarebbe priva di vitalità, se non si avessero di mira l’uomo e le sue attività, e biasima quanti ritengono di farla ricorrendo ai numeri riportati dai censimenti che risultano falsi per difetto o per eccesso, e lo storico ricorda, ad es., le attuali dichiarazioni dei redditi. Sicché, come in tutti i settori, anche negli studi storici non mancano gli arrivisti e i profittatori che, pur di farsi strada, riportano lucciole per lanterne, disorientando i lettori. A conferma di quanto asserisce, il Nostro chiama in causa i maestri Virgilio Titone e Helmut Koenigsberger che tanto scrissero e si adoperarono per dare senso e valorizzare la storia come storia dell’uomo, delle sue attività e degli interessi, pratici o culturali che siano. Altro che date e fatti!
Non si ferma a ricordare soltanto i colloqui con Titone e Koenigsberger. Messina, forte della sua formazione classica, interroga anche scrittori antichi e moderni. Egli va a ripescare scritti di Aristotele, di Cicerone, ma anche di Voltaire, Braudel e tanti altri autorevoli storici che considerano storia ogni prodotto umano. Ed è qui che dà spazio a Voltaire (ricordiamo, a proposito, il saggio Voltaire e il mondo classico, Palermo 1976), quando enumera le quattro età felici (quella di Filippo e Alessandro, di Cesare e Augusto, dei Medici, di Luigi XIV). «Ma a quella felicità delle età – scrive il Nostro – non corrispondeva la felicità degli uomini, ben lo sapeva Voltaire […] che tutti i secoli, anche le età felici, hanno in comune una cosa, la cattiveria degli uomini, e per essa sono simili» (ib., p. 590).
Il Discorso sulla storia è la parte più interessante dell’opera. L’autore lo colloca alla fine, dopo la narrazione, perché lo ritiene – a nostro parere – consequenziale ad essa, ma di per sé è la concezione della storia che ha maturato nel corso di tanti decenni e che ha ritenuto di pubblicare per contrastare gli abusi e gli errori che spesso si fanno, scrivendo di storia. Anche perché per fare storia occorre essere padroni dei ferri del mestiere. Non si può riesumare il passato o anche riprendere la realtà di ogni giorno senza sapere scrivere. L’affermazione è sua, e ne prendiamo atto. Non può essere diversamente. La narrazione ha bisogno, oltre della conoscenza di ciò che si vuole narrare, di chi sappia scriverla con i crismi propri della scrittura. Contro chi semplicemente esuma i fatti e i dati statistici, senza raccontare ciò che effettivamente è avvenuto e quale la vita degli uomini di quel dato momento, Messina scrive:
«Per potere scrivere la storia degli uomini, si deve avere innanzi tutto sensibilità, molta sensibilità umana, e pure lo storico dev’essere uno scrittore. Dopo gli esperimenti degli storici scientifici e tante altre stravaganze e illusioni e delusioni storiografiche, universalmente si è avvertita, sempre più, l’esigenza di un ritorno al racconto. Per raccontare si deve sapere scrivere e chi sa scrivere si chiama scrittore; lui sa entrare nella vita degli uomini, anche di epoche lontane, rappresentarla con le giuste parole, con le sfumature che sono essenziali, e può raccontare dunque anche la storia, sa come va narrata, come confezionare il racconto e adattarlo al soggetto, su misura, volta per volta, conosce i segreti dell’arte» (Sicilia 1492-1799, pp. 572-573).
Calogero Messina scrive e afferma con i fatti il suo pensiero, perché, oltre ad essere uno storico nel senso vero del termine, è – ribadiamo – uno scrittore e poeta. Egli nel silenzio del suo studio parla e scrive con gli uomini di ogni tempo e li risuscita, mostrandone gli interessi e l’umanità che li fece agire ed operare nella consapevolezza e nella libertà dell’essere uomini, che è una caratteristica a cui ognuno dovrebbe mirare. Tutte le sue opere sono narrazioni e racconti, ma in particolare ricordiamo Volevano l’Inquisizione (1992) e I vendicatori (1995), che sono romanzi molto allusivi e accattivanti. Prendendo spunto, nel primo, dell’Inquisizione in Sicilia, lo scrittore mette a fuoco la Sicilia di fine Settecento, quando i Siciliani trovavano gusto e divertimento negli autos de fe e volevano che si continuasse a tenere in piedi quell’istituto che tanto danno agli uomini e alla cultura aveva arrecato in Sicilia e altrove; nel secondo, I vendicatori (vedi «Spiragli», n.s. A. I, 2020, n. 1, pp. 55-56), l’autore sintetizza con molta bravura la realtà storica di un periodo molto travagliato della Sicilia, a cavallo del XIX e degli inizi del XX secolo, in cui la classe dominante padronale, che aveva dalla sua parte il potere costituito, imponeva la sua legge sfruttatrice, pronta a farsi valere con la forza delle armi e della messa a tacere per sempre. Entrambi i romanzi nascono da studi e ricerche fatte nel corso degli anni. Ne I vendicatori riprende l’ultimo periodo di vita e poi l’uccisione di Lorenzo Panepinto, su cui Messina ha scritto tanto (In giro per la Sicilia con «La Plebe» (1902- 1905); Il caso Panepinto), e sono scritti relativi al periodo tra Otto e primo Novecento in Sicilia, a S. Stefano Quisquina, paese dell’agrigentino, dove forte e sentito era il riscatto sociale della povera gente, dei contadini sottomessi ai grandi proprietari terrieri e agli intermediari che erano delle vere e proprie sanguisughe. L’autore sembra essere in mezzo alla sua gente e ci pare sentire ogni battuta e il tono della voce, la parlata dell’area agrigentina, che poi è quella del Nostro, perché caratteristica della sua scrittura – ripetiamo – è il tono della voce, la cadenza che sa imprimere e fa sentire nei suoi scritti.
I registri utilizzati – come si può notare – sono mutevoli, cambiano alla bisogna; vanno dalla narrazione vera e propria, sempre partecipata, al racconto, popolato da personaggi che fanno la storia e la vivono, e alla poesia, perché all’occorrenza se ne serve per dare voce e canto a uomini antichi o del più recente passato, e nelle sillogi l’umanità del Messina si manifesta in una luce più chiara. Leggiamo in Sodalitas (Palermo,1999), ad es., la poesia “A Lorenzo Panepinto” (ripubblicata in «Spiragli», A. XXIII, 2011, n. 1-4, p. 44), nella quale il poeta rivive, rappresentandoselo, quel brutto momento dell’uccisione di Panepinto («Un pane sotto il braccio, / tornavi ai tuoi figli e cadevi / come un tronco possente / dalla perfidia vile / spezzato / davanti alla sposa»), mentre i poveri suoi compaesani piangono, senza darsi pace, il loro maestro e la guida. Il poeta parla con l’estinto e riferisce, mentre è silenzio intorno:
Ove i vicoli odorano di fieno
la povera gente che amasti
ritrovo la sera.
Ti ricordano e conversano teco
i vecchietti seduti alla soglia,
le parole confuse al calpestio
dei muli, al belar delle capre.
[…]
Il lamento degli umili
riascolti la sera
e torni a parlare con loro
e li sproni a sperare.
Poesia e storia sono in simbiosi e il poeta trova il modo e il tono giusto per calarsi nella realtà ed evidenziare pregi e difetti dell’uomo di ogni tempo. Si legga anche “A Publio Ovidio Nasone” («Spiragli», n.s. A. I, 2020, n. 2), scritta a proposito di un viaggio nei luoghi in cui nell’8 d.C. Ovidio fu esiliato. Il Messina si compenetrò nella solitudine e nella sofferenza che Ovidio dovette patire lontano dalla sposa e dalla sua Roma, e ne condivide il dolore in versi molto toccanti («Su questi lidi / in orrida solitudine / piangevi la tua sorte / tra nemiche genti. / Maledivi i tuoi versi / ai quali dovevi la tua condanna, / ma erano i versi / che alleviavano ora le tue pene, / nell’esilio la Musa ti rimaneva fedele compagna / e ti dava speranza di fama / dopo la morte. / Ma tu ripensavi a Roma lontana […] / Tua colpa fu l’aver visto / cose che non dovevi vedere, / l’avere avuto gli occhi / fu il tuo peccato, o Nasone. / E ti mandarono in questa rimota / terra: qui finiva l’imperio di Roma / e il mondo») e non può non immedesimarsi e fare suo quel dolore dovuto a privazione di cose e di affetti. Leggiamo:
In questa spiaggia deserta ti ritrovo,
compagno della mia solitudine;
io vengo dalla lontana isola del sole
che pure vedesti con i tuoi occhi
in compagnia di Pompeo Macro poeta
tuo parente e amico:
mirasti il cielo splendente
delle fiamme dell’Etna,
sentisti il forte odore di zolfo,
cantasti l’eterna primavera siciliana.
E qui sospiravi i lidi dell’isola mia
diversi da quelli dei Geti.
Sento impetuoso il vento
anche in questo luglio,
s’inseguono le onde del mare
si adagiano alla riva,
ti cercano ancora,
chiedono a me qualcosa di te:
io canto soltanto i tuoi versi
e mi lascio bagnare le mani
dal mare che parlava con te…
Calogero Messina anche nella poesia è – come può notarsi – uno storico attento, rispettoso dell’uomo che, spesso coinvolto in situazioni fattuali più grandi di lui, resiste, reagisce oppure subisce, come Ovidio, pur tenendo alto il suo essere e la sua libertà interiore. Sicché il merito del Nostro è quello di mantenersi in linea non solo con pensatori e storici famosi – come si è visto – ma con i principi espressi da Aristotele nella Poetica, specie quando afferma che la poesia tende a rappresentare l’universale, a differenza della storia che ha per oggetto il particolare (1451 a 35 b 11) e quando asserisce che il poeta deve immaginarsi e porsi «dinanzi agli occhi» la persona o le cose di cui si sta interessando (1455 a 22-26). È quello che notiamo negli esempi riportati. Ne deriva che compito dello storico, e quindi della storia, è disvelare il vero essere dell’uomo, mentre secondari o per certi aspetti di aiuto a questo disvelamento sono i fatti, le date, le narrazioni di eventi vari. *** Sicilia 1492-1799. Un campionario delle crudeltà umane è la narrazione di tre secoli di storia siciliana da cui prende corpo la poderosa opera di Calogero Messina. Egli mette in evidenza – come recita il titolo – l’agire dell’uomo che, dimentico del bene comune, si abbandona ad ogni sorta di crudeltà, vero lupo dell’altro uomo spesso indifeso e abbandonato anche da chi dovrebbe tutelarlo e difenderlo, responsabile della legalità o ministro della religione che sia. L’anno 1492 si rifà, più che alla scoperta dell’America, alla conquista e all’annessione di Granada alla Spagna di Ferdinando II, mentre il 1799, regnante Ferdinando III di Sicilia, chiude con una grave carestia e rivolte un po’ in tutta l’Isola, che stava rivivendo uno dei tanti periodi più bui della sua storia. Nei 6 capitoli, suddivisi in paragrafi intitolati, di cui si compone l’opera, la Sicilia è presentata nelle luci e nelle ombre che da sempre la caratterizzano; una Sicilia, questa del Messina, che, insieme con il contributo di storici italiani e stranieri (Titone, Koenigsberger, Braudel ed altri), perde il suo alone oleografico e si manifesta così come è sempre stata ed è, perché alla realtà storica, facendo propria l’asserzione di Virgilio Titone, ritiene e abbina una realtà biologica trasmissibile nel tempo. Il primo capitolo dà spazio alla cacciata degli Ebrei, suggerita dall’Inquisitore generale e voluta dal re in Spagna e nei suoi domini. L’Autore, pur ricordando che gli Ebrei non erano mai stati benvoluti un po’ dovunque, non soltanto mette in risalto la reazione dei Siciliani alla promulgazione dell’editto, ma la pressione che fanno, perché il re lo annulli, considerato il grande contributo che gli Ebrei davano all’economia e alla crescita socio-culturale della Sicilia. Non otterranno niente e non passerà molto che, messa in atto l’espulsione (12 genna i o 1793) , essi stessi li perseguiteranno e si faranno complici e «familiari» dei persecutori, partecipando festosi ai roghi, anche se molti lamentarono l’abuso e il ricorso agli autos de fe, coinvolgendo il Parlamento, ma non ottennero niente. Una lezione che si evince è quella che occorre conoscere il passato per potere leggere e vivere il presente; siamo ai corsi e ricorsi della storia di vichiana memoria. Un ricorso, di cui tanto si parla e si abusa, ce lo offre la pandemia, che fece fermare le attività produttive, con il rincaro dei prezzi delle materie prime, dei beni di prima necessità e la chiusura di tanti esercizi che non possono andare dietro alle sempre maggiorate tasse e al rincaro delle bollette. Ne consegue che l’Italia, da potenza industriale qual era, è stata ridotta allo stremo. Tutto questo per l’ingordigia di pochi che profittano della povera gente e dei lavoratori per arricchirsi e fare da padroni.
Se prima si nascondeva il frumento per venderlo maggiorato, ora si ricorre a tutt’altro per spremere di più e dominare. Qui, ciò che Messina mette a fuoco è l’aberrazione dei pochi che in quella occasione coinvolsero i molti e tutti concorsero all’immiserimento della Sicilia. Venne meno il commercio e per forza maggiore tante attività dovettero chiudere, non ci fu circolazione di moneta e quel che aggravava ancor più la situazione fu la richiesta di denaro, ora per un motivo ora per un altro, da parte dei re. Nel paragrafo «E li chiamavano donativi» scrive:
«Nei secoli passati c’erano state le collette, imposizioni straordinarie, una tantum, sui beni allodiali; erano state previste soltanto nei seguenti casi: guerra o veicoli d’invasione o necessità di apprestamenti difensivi o calamità naturali; incoronazione del re; matrimonio e dotazione di una figlia odi una sorella del re; cerimonia per armare cavaliere un figlio un fratello del re; riscatto del re o di un suo intimo congiunto dai nemici. […] Regnando Ferdinando il Cattolico, dal 1502, il Parlamento in Sicilia si cominciò a celebrare ogni tre anni e ogni volta si concedette, autonomamente, un donativo di trecento mila fiorini; in tal modo si assicurò all’erario la rendita annuale di centomila fiorini, alla quale spesso si aggiungevano le somme di altri donativi detti straordinari, che potevano essere concessi in altri parlamenti anch’essi straordinari, convocati nel corso dei tre anni» (ib., pp. 26-27).
Come potevano i Siciliani godere dei beni di loro acquisto e di quelli della loro terra generosa, ricca di frumento e di altri prodotti di prima necessità, se l’erario e gabelle varie non davano loro un minimo di tranquillità e di pace, per cui spesso erano costretti a ribellarsi e a rivendicare il loro esserci? Lo storico mette a nudo questa realtà che gli fa toccare con mano un campionario di crudeltà mai da altri storici evidenziato.
Quest’aspetto si fa più chiaro nel secondo capitolo che è tutto un susseguirsi di rivolte, di cacciata di viceré, di lotte tra baroni e conti (si legga il caso di Sciacca), di congiure, di invasioni dei corsari, e ancora catastrofi naturali e la necessità di fortificare città e territori di facile bersaglio dei Turchi. La narrazione è sempre di facile lettura, scorrevole, invitante; Messina sembra quasi prendere per mano il lettore e coinvolgerlo in fatti e situazioni che altrimenti non avrebbe potuto conoscere proprio per l’astrusità di certi testi che, invece di avvicinare, allontanano. E questo, a Messina scrittore di storia, si deve riconoscere, soprattutto perché, nutrito di classici antichi e moderni, spesso chiamati in causa, espone con lucidità e chiarezza, dando risalto alla componente umana. Non potrebbe essere diversamente, dato che la storia è un prodotto umano.
Sempre in questo secondo capitolo Messina, in linea con gli studi di Titone e di Koenigsberger, fa il punto sull’istituto spagnolo del viceré, da cui la Sicilia fu governata. Scrive:
«Il viceré giurava di mantenere i privilegi, le costituzioni e i capitoli del regno di Sicilia, che si considerava una nazione, indipendente, aveva un suo antico parlamento, col quale il viceré doveva venire a compromesso, ma non era difficile; durante il viceregno spagnolo il tanto celebrato Parlamento siciliano non ebbe le funzioni che generalmente si attribuiscono a tale istituto…» (ib., p. 41).
Fu proprio questo il motivo per cui le cose non andavano bene in Sicilia! Scontenta rimaneva la parte baronale contraria che non vedeva tutelato il suo interesse e tanto più la popol a z ione che mol t o spe s s o e r a abbandonata a se stessa. L’analisi di Messina è convincente e a dimostrarla sono gli attriti tra i vari istituti o i ceti sociali sempre in agitazione e pronti a scendere per le strade e protestare in modo brutale. Un aspetto, di cui tiene debito conto l’Autore, è quello socio-culturale. Lo storico sembra entrare nelle case, parlare con i popolani dei vari rioni, per rendersi conto da vicino della misera realtà in cui erano costretti a vivere, e ci pare rivedere le stesse condizioni di vita di tempi non troppo lontani SAGGI da noi. Questo perché Messina, come Titone dei Riveli e platee del regno di Sicilia (1961) che tiene sempre presente, non ha fiducia nei censimenti che nel tempo si facevano e ancora si fanno; preferisce leggere oltre lo scritto i documenti, le opere di vario genere e soltanto così ottiene i risultati che mette a disposizione di tutti. Egli sa che questa è storia, con personaggi importanti o di minor conto eppure di rilievo, così come gli scrittori e gli uomini di scienza che tanto lustro danno tuttora alla Sicilia.
Il terzo capitolo, che tratta della storia siciliana del secondo Cinquecento, presenta una Sicilia volta a venire incontro alle richieste di vario genere dei sovrani spagnoli (Carlo V, poi il successore suo figlio Filippo II), impegnati, da una parte, nella guerra contro la Francia, dall’altra, nella lotta contro i corsari che infestavano il Mediterraneo, motivi per cui chiedevano donativi e, insieme con altre uscite, immiserivano la Sicilia, di per sé ricca, come appariva ai tanti visitatori e stranieri che non mancavano di apprezzarne la fertilità e la bontà dei suoi prodotti, la produzione e l’eccellente qualità del suo frumento.
Il nostro autore si avvale, come fa sempre, dell’apporto di autorevoli colleghi che lo hanno preceduto e, ricordando il suo maestro Virgilio Titone, scrive che «il donativo, per il modo in cui era distribuito, poteva costituire un peso grave per i più poveri e che non pochi morivano di fame quando andava male il raccolto» e che «più positivo che negativo si doveva considerare il bilancio economico della dominazione spagnola, nonostante la diffusa, indigena corruzione dell’isola». In effetti, ad aggravare la situazione furono i traffici illegali, il dissidio tra gli appartenenti dei vari istituti (parlamentari e inquisitori), l’accaparramento delle derrate alimentari per venderle a prezzo maggiorato, la complicità degli uomini di legge a camuffare e tutelare i malavitosi, liberi di offendere o uccidere, rimanendo impuniti. Si consolida così come organizzazione criminosa la mafia. Ne aveva scritto Titone, e dalla narrazione del Messina emerge chiara la matrice mafiosa che lega uomini di ogni ceto sociale, pronti a spargere sangue innocente, pur di raggiungere i loro obiettivi. Complicità, abusi, delitti impuniti e ingiustizie erano all’ordine del giorno. L’autore ricorda la libertà concessa al Conte di Asaro, colpevole di «un altro fatto della più efferata crudeltà », scarcerato per l’intercessione di Don Cesare Lanza, a sua volta, uccisore della figlia, la baronessa di Carini, di cui soltanto il poeta popolare tramandò la storia e che Messina riporta.
L’immagine che della Sicilia viene fuori da questa lettura è quella di una terra ricca e generosa presa di mira e sfruttata da uomini che agivano per tornaconto, per i quali ogni occasione era buona per arricchirsi alle spalle di chi lavorava per sé e per gli altri e persino di chi soffriva, come quando ci fu la peste, tra il 1575-’76. Riportiamo:
«Ad aggravare le cose in Sicilia arrivò anche la peste […], e portò la morte anche a Palermo, dove i suggerimenti del famoso medico Gian Filippo Ingrassia ne limitarono le conseguenze, ma si ripeterono gli episodi della più atroce crudeltà: propagavano il contagio le robe infette rubate e rivendute, e il Presidente de Regno diede gli ordini più rigorosi, che servissero di monito, e si videro degli individui che riconosciuti rei di quel traffico, furono trascinati alla coda dei cavalli e strozzati, o impalati e lacerati nelle carni e buttati dallo Steri (ib., p. 133).
Sfruttata e offesa era la Sicilia in questo lasso di tempo narrato ed esaminato dal nostro autore e sarà ancora così, fin quando l’uomo non comprenderà che occorre essere consapevole di sé, in quanto tale, e da consapevole trattare gli altri da uomini. Soltanto allora subentrerà il rispetto per i simili e per la terra ospitale. Ma penso alla considerazione di Don Fabrizio, a fine colloquio con Chevalley, e rattrista e lascia senza parola quell’«irredimibile». Anche perché, andando avanti nella narrazione (siamo al quarto capitolo, Un secolo di lusso, di miseria e di congiure), ci rendiamo conto che i problemi della Sicilia non hanno mai avuto e non hanno tuttora un’adeguata soluzione, anzi si complicano di più. Ed è ciò che avvenne nel XVII secolo, ricco di accademie di ogni tipo e allo stesso modo di misfatti e crudeltà inaudite, di carestie, una dietro l’altra, e di rivolte per la mancanza di frumento e per il malgoverno, tranne poche eccezioni, come quello del viceré Ossuna (1611-1616), severo contro il male imperante e volto a instaurare il bene comune , nel rispetto della legge , applicandola anche nei confronti di nobili e di amministratori, senza alcuna particolarità; o quello del Duca d’Albuquerque e di qualche altro, ma erano malvisti dai titolati e dai nobili, perché non avevano alcun riguardo per loro, abituati, com’erano ad essere i privilegiati anche nell’impunità.
«Il Duca d’Albuquerque – scrive Messina, ma va riferito anche ad altri pochi viceré – diede prove della sua imparzialità; non ebbe riguardo per la discendenza di Fabrizio Riggio, che nel 1669 rubò con un complice gli argenti della chiesa palermitana di S. Domenico: fece condannare entrambi alla galea per quindici anni e volle che fossero condotti per la città con le mani legate dietro la schiena, e per impedire che, come accadeva, i parenti lo strappassero alla giustizia, ordinò che li portassero al remo il capitano della città e i suoi giudici, scortati dalle loro guardie e da una compagnia di soldati spagnoli e da un’altra di borgognoni» (ib., p. 261).
La Spagna, presa com’era dalle guerre e dai molti problemi che travagliavano le terre di suo dominio, si fidava dei suoi viceré e dei delegati, ma spesso si veniva a creare una loro connivenza con i poteri forti locali che agivano ed operavano per il loro esclusivo tornaconto, trascurando le popolazioni che, per questo, erano sempre sul piede di guerra.
Il Seicento fu particolarmente un secolo di contrasti. Da ciò che si evince dalla lettura del volume, non avvengono soltanto tra governanti e popolazioni, ma tra città e città. Il municipalismo era molto sentito e ognuna di esse tutelava i suoi privilegi e voleva superare o essere alla pari con l’antagonista, come avviene tra Palermo e Messina, sempre in attrito, questa, per volere battere moneta o per avere in sede il viceré e pronta, tradendo, a passare dalla parte nemica. Ma fu un secolo anche di carestie e di occultamento di grano, per venderlo a prezzo maggiorato. Di qui le sommosse e le rivolte (vedi quella di Giuseppe d’Alesi, volta a sovvertire l’ordine costituito), che tanto danno arrecarono alle popolazioni le quali, patendo miseria e fame, subirono morti e continuo ripetersi delle pesti che decimarono tanta gente e videro anche casi di sciacallaggio e di libidine contro donne ammalate o morte.
L’opera del Messina si rivela un vero e proprio «campionario delle crudeltà umane». Se consideriamo gli eventi, l’agire dell’uomo, le avversità dovute a fenomeni naturali, la persistente pirateria che costò molto in uomini e cose, con le conseguenti continue allerte e richieste di donativi straordinari da parte dei governanti e il fiato sospeso delle popolazioni, ci rendiamo conto che la Sicilia, da terra ricca e privilegiata qual era, soffrì fame e miseria, e a piangerne le conseguenze fu sempre la povera gente, costretta a subire le angherie dei potenti e dei banditi che, al pari dei pirati, saccheggiavano e uccidevano nelle campagne e nelle città. Sicché lo storico presenta la Sicilia così com’era. Ci sono i fatti, le date, i personaggi, ma – è il caso di ripeterlo – sono in funzione di un unico contesto, dove tutti operano e agiscono, mettendo a nudo un’umanità sofferente per colpa di chi vuole prevalere sugli altri con la forza del denaro, con le uccisioni e gli abusi di ogni sorta.
Emerge da tutta la narrazione che il potere viceregio e le autorità dei diversi istituti si davano da fare per eliminare quei mali sociali che erano di ostacolo e pericolo per tutti, anche se c’erano coloro che, traendone vantaggi, ostacolavano e nascondevano i malvagi, di cui spesso si servivano per raggiungere i loro scopi. Il Messina riporta, tra gli altri, l’operato del viceré Duca d’Ossuna, quando, costatando le complicità, «voleva che per nessuno si facessero eccezioni nell’amministrazione della giustizia, che non si chiudessero gli occhi neppure per i nobili» e, quando ci fu un furto nella Tavola di Palermo, minaccerà e incarcererà pretore e senatori, e li avrebbe anche esiliati, se non avessero consegnato il cassiere responsabile del furto. Ed essi «che avevano le loro responsabilità nella faccenda, trovarono il cassiere e lo consegnarono; allora furono scarcerati» (ib., p. 186).
I viceré, a seconda dei casi, sapevano bene usare il bastone o la carota. Il Duca d’Ossuna ed altri, ad es., erano molto criticati dai nobili, ostacolati com’erano nei loro illeciti, ma essi, incuranti delle dicerie, usavano il bastone. All’occorrenza, però, concedevano il contentino, la carota, sempre bene accolta e capace di far dimenticare i problemi della miseria e della fame che rendevano quasi impossibile la vita. Un paragrafo del quarto capitolo ha come titolo: «La festa dissolveva la miseria» e, in effetti, da tutto il contesto della narrazione emerge che ogni occasione era buona per fare festa. Feste ad alto livello, con tanto sfarzo, si facevano sia nel palazzo vicereale in occasione di eventi di grande rilievo (matrimoni reali o successioni, riconferme di viceré o vittorie), ma anche nelle piazze e per le strade e il popolo vi partecipava, dimentico di tutto.
Erano motivo di festa persino le condanne a morte o l’auspicio di un matrimonio. A proposito, leggiamo:
«Nel marzo del 1689 si seppe a Palermo della prematura morte della moglie di Carlo II, Maria Luisa di Borbone; si celebrarono i funerali. Non era nato ancora l’erede: si tornava a sperare per il nuovo matrimonio del Re Cattolico, e per esso si cantò il Te Deum il 21 settembre, e il viceré tenne una festa nel Palazzo Reale e lì si gioco e si ballò; altre feste si fecero nel 1690 per iniziativa del senato palermitano: giostre di cavalieri, cavalcate, giuochi di fuoco» (ib., p. 289).
Lo storico dedica spazio, oltre alle pesti che decimavano le popolazioni, anche al terremoto del 1693, portatore di distruzione e di morte, che desolò soprattutto Catania e la Sicilia orientale, ma anche nell’interno, e a Palermo fece sentire i suoi effetti catastrofici, e tutti si rivolgevano ai santi Patroni, a santa Rosalia, e facevano voti per scongiurare il peggio. Anche in questo triste evento non mancò lo sciacallaggio, e il Messina riporta una pagina nera di Agostino Gallo, dove con vile crudeltà i ladri inveivano contro morti e feriti per impossessarsi dell’oro che avevano addosso; ma trascrive anche alcuni versi di un canto popolare che al Nostro ricordava un suo informatore: «Morsiru barunati e cu marchisi / li picciliddi cu l’occhiuzzi chiusi, / Maria si li pigliò quannu li ‘ntisi. / Vo’ sapiri cu su’ l’addilurusi? / L’afflitti, scunsulati Catanisi; / Catania nni faciva principi e conti / cchiù ricchi di Palermu sì cotanti. /…». Scrivevamo più sopra, a proposito della poesia, di disvelamento. Qui il poeta popolare mette a nudo la realtà, ce la presenta proprio come appariva agli occhi del poeta, quasi a farcela vedere («… cci su li mura ddà, ‘un cc’è cchiù nuddu. / Cadì lu campanaru e la campana / e ’nautru jornu lu tettu e li mura; …»). Lo storico e il poeta vanno di pari passo e fanno riemergere il passato con tutto ciò che si porta dietro; viene fuori che, subito dopo il terremoto, ci fu la ripresa e la ricostruzione e si tornò alla vita di sempre, cosa che non capita ai nostri giorni. Scrive:
«C’è molto da apprendere da questa storia. Ridotti allo stremo, i siciliani di allora mostrarono subito di volere la ricostruzione e non l’aspettarono dalle istituzioni; furono pronti a impegnarsi per primi per raggiungere quel traguardo; l’operosa gente di Catania, di Noto e di altri centri sbalordì per la capacità di ripresa e la sollecitudine con cui la realizzarono, e le città risorsero più splendide di prima, […]. Se guardiamo a quello che è accaduto nel nostro tempo in zone della Sicilia distrutte da altri terremoti, non troviamo la serietà di quei cittadini, il loro senso di responsabilità e di concretezza, la loro capacità di realizzazione, ma tutt’altro» (ib., p. 297).
La tempistica è di richiamo, anzi suona come un severo rimprovero a governanti e uomini del nostro tempo. Come non concordare con Messina che tiene presente e tramanda con orgoglio la lezione del maestro, l’integerrimo Virgilio Titone?
Nel capitolo quinto (Spagnoli, Piemontesi, Austriaci) leggiamo di una Sicilia che cambia governanti per accordi presi dalle grandi potenze, ma non risente di alcun miglioramento, considerati i problemi insoluti e quelli nuovi, compreso un risentimento antispagnolo che contribuiva ad alimentare malessere tra la popolazione e, soprattutto, tra i Messinesi che avevano concittadini o anche parenti in esilio e i loro beni confiscati. La situazione rientrò nella norma, quando Filippo v ordinò il loro ritorno in patria e la restituzione dei beni confiscati, ma non fu sradicato l’antispagnolismo, a causa anche delle voci di riassestamento territoriale che, anche se con ritardo, giungevano in Sicilia; ma c’era pure il banditismo, che dava filo da torcere nelle città come nelle campagne, e un commercio ridotto al minimo per la carenza di frumento. Problemi vecchi e nuovi che mettevano in difficoltà il viceré, costretto a chiedere rinforzi a Madrid per i tumulti, la sicurezza interna e il timore di un attacco austriaco. Lo storico così scrive:
«In realtà né Luigi XIV né Filippo V ritenevano la Sicilia in pericolo imminente e non corrispondevano alle pressanti richieste di aiuti, anche perché vedevano che altrove ce ne fosse più bisogno; davano soltanto le loro assicurazioni che l’avrebbero soccorsa, qualora fosse stato necessario. Si arrivò anzi a chiedere degli uomini alla stessa Sicilia, come fece il viceré di Napoli, il Villena, col nuovo viceré dell’isola, lo Spinola, ma non ne ottenne uno solo» (ib., p. 297).
Eppure sotto il governo spagnolo in quei tredici anni di primo Settecento ci furono tanti tumulti e uccisioni di innocenti, accusati di avere soltanto nominato Carlo VI o ritenuti traditori oppure per avere inneggiato alla repubblica. Si lottò anche contro la criminalità organizzata, ma si ottenne poco, perché protetta da alti dignitari e da nobili. «Appariva evidente la corruzione, a tutti i livelli – scrive Messina -; si sapeva delle complicità e solo una minima parte erano i delitti che si scoprivano, e anche se si scoprivano, restavano spesso impuniti». Documenti d’archivi di mezza Europa letti (Spagna, Francia, Austria, Inghilterra, tramite anche l’apporto dello storico H. Koenigsberger) e la consultazione di scritti di autori coevi e contemporanei, hanno permesso all’autore di fare un racconto abbastanza ricco e dettagliato. Come in un documentario, in cui le riprese sono tutte ben collegate tra esse, il lettore ne è coinvolto e diviene partecipe lui stesso di ciò che stava avvenendo in quel dato periodo.
In Sicilia, anche con Vittorio Amedeo II re (1713-1718), non ci furono miglioramenti. Se in un primo tempo i Siciliani furono contenti per avere finalmente un re proprio, subito se ne pentirono, ritrovandosi dopo appena un anno governati dal viceré Maffei. Sicché «si smorzarono gli entusiasmi e non piacevano gli uomini del Duca, apparivano freddi, sempre più apatici, troppo diversi dai siciliani e dagli spagnoli». Dalla lettura, per questo ed altri motivi, fra l’altro sanciti dal trattato di Utrecht, la Spagna sperava di riprendersi la Sicilia e vi tentò nel 1718 con l’aiuto del Cardinale Alberoni. A Palermo fu festa grande, ma non cessarono i tafferugli, i tumulti e tanti morti. Messina, a proposito, scrive:
«Il ritorno degli spagnoli non contribuiva alla soluzione dei gravi problemi che affliggevano la Sicilia; si respirava ancora aria di anarchia e si scatenavano i diversi e contrastanti interessi, gli egoismi individuali più ottusi e le particolarità municipalistiche. Grave era la confusione e infiniti disordini si ripetevano dovunque a tutti i livelli, senza un re sicuro e in diverse parti senza nemmeno l’autorità religiosa, pareva che i siciliani volessero fare di testa propria» (ib., p. 349).
Il capitolo è ricco di riferimenti e di particolari che ci fanno rendere conto di come le cose andavano in Sicilia nella prima metà del Settecento, nonostante i grandi uomini di cultura e di scienza (come negli altri capitoli, anche qui sono ricordati alcuni, tra cui G.B. Caruso, molto stimato dal Muratori, e il medico poeta e filosofo T. Campailla), che gli altri Paesi le invidiavano.
Dalla lettura si evince che la Spagna avrebbe voluto migliorare le condizioni della Sicilia, ma era coinvolta nella guerra della Quadruplice Alleanza, per cui dovette affrontare i nemici fuori e dentro la Sicilia, divisa, contrastata e maggiormente tassata per quella guerra che il Messina riporta nelle varie fasi e negli accordi finali tra il generale tedesco Mercy e il Marchese di Lede conclusisi con il trattato dell’Aja (1720) che assegnò la Sicilia all’Austria di Carlo VI, che divenne III di Sicilia.
Accattivante – come leggiamo – fu all’inizio l’impatto del re con i Siciliani, ma non mancò molto, «si vide che gli austriaci non riuscivano a familiarizzare con i siciliani, sia per il loro carattere, sia per la loro lingua, che sembrava barbara dai suoni, sia per la fama che avevano di eretici e di essere dediti a usi sciocchi e triviali» (ib. p. 360). Ci fu incomprensione e si capì, da parte del nuovo governo, tanto che si cercò di lasciare invariate le usanze per non indisporre i più suscettibili e mettersi contro la popolazione.
Uscita dalla guerra, la Sicilia fu chiamata a fare donativi per motivi vari, come sempre, ma niente o poco veniva fatto per migliorare le condizioni di vita delle città e dei paesi, e ci fu uno scontento diffuso, anche in ambito ecclesiastico. Il governo si rese conto che bisognava ripristinare la Santa Inquisizione e, al tempo stesso, ricorrere anche alle feste per distrarre dalla triste quotidianità. Tra le tante feste il Messina riporta la partecipazione di popolo all’autos de fe di Suor Geltruda e Fra’ Romualdo, e scrive:
«Il Kamen e altri storici hanno mostrato la popolarità degli autos de fe che si celebravano nella Spagna; ciò che avveniva in Spagna, si vedeva anche in Sicilia, e la mancanza dei roghi per un lungo tempo contribuì a rendere la partecipazione allo spettacolo e al rogo del 1724 ancor più massiccia, appassionata, frenetica» (ib., p. 371).
Con gli Austriaci non fu risolto il problema del brigantaggio, la corruzione era abbastanza diffusa e tante terre abbandonate. «Tragico fu l’esito della politica austriaca; sconcertante la pressione fiscale – scrive Messina -. Le mie ricerche non hanno potuto che riconfermare il quadro che altri hanno disegnato della Sicilia austriaca e che qualcuno vorrebbe diverso, una Sicilia spremuta senza pietà, oppressa continuamente» (ib., p. 386). Lo storico, a proposito, in un paragrafo di Sicilia e Spagna nel Settecento (Palermo 1986), definisce la Sicilia «irriducibile» e ciò significa che essa ce l’ha nel suo DNA l’apatia e l’indifferenza al nuovo e al cambiamento, se consideriamo quanto scrisse il Tomasi e quello che tuttora, a distanza di quattro secoli, costatiamo.
Il sesto ed ultimo capitolo (Un re per Napoli e la Sicilia) copre l’arco di tempo che va dal ritorno degli Spagnoli, con Carlo III re, alla venuta in Sicilia di Ferdinando IV di Napoli, III di Sicilia (1734-1799). Di questo periodo emerge un quadro non tanto bello, come in precedenza. Non ci sono particolari cambiamenti, se non quello del distacco del Regno delle Due Sicilie dalla Spagna, anche se re Ferdinando regnerà sotto la regia paterna (Messina riporta come es. di rilievo l’espulsione dei Gesuiti del 1767) almeno fino al 1776, quando allontanò il Tanucci, sostituendolo con il Marchese della Sambuca. Si cercò di eliminare gli abusi di ogni genere (irregolarità dei matrimoni, sperperi eccessivi per i funerali, il problema dei proietti), di fortificare città e paesi e di fare delle migliorie (sanificazione del territorio, attrezzandolo di strade meglio percorribili per le persone e le cose, dato che si voleva incentivare il commercio, valorizzando i prodotti siciliani). I re seguivano da vicino ciò che occorreva e si faceva per la Sicilia e i Siciliani, di cui erano riconoscenti per la loro fedeltà e l’attaccamento alla Spagna. Scrive, a proposito, lo storico:
«L’attenzione e le preoccupazioni del re di Spagna erano rivolte alla Sicilia non meno che a Napoli; seguiva le vicende e le controversie dell’isola, sulle qualei dettagliate notizie gli forniva il Tanucci, e ne prendeva atto, approvava o disapprovava le iniziative e le intenzioni, dava consigli, esortazioni, ordini» (ib., p. 436).
Spesso però la buona volontà veniva vanificata dal sopraggiungere di calamità naturali (peste, carestie), che causavano morti e danni con conseguenti mancanze di grano, di riversamento nelle città di affamati provenienti dall’entroterra e dalle campagne, di disordini e tumulti, il più delle volte terminati con dure condanne ed esecuzioni. Non manca il Messina di sottolineare che tutto il più delle volte era dovuto al malgoverno di chi era preposto a fare osservare le leggi e a tutelare la gente. Molti amministratori facevano loschi affari con i furbi e con i delinquenti che, nascondendo il grano e i generi di prima necessità, speculavano, vendendolo a caro prezzo, come nel passato. Sicché le cose in Sicilia cambiavano per restare sempre invariate; concetto ripetuto, ma non si può fare a meno di ricordare. Come potevano i popolani esasperati non darsi ai furti e alle malefatte di ogni genere? E per queste ci furono condanne e decapitazioni che rendevano alla gente un lugubre spettacolo, a cui ormai era da tempo abituata.
La cacciata di Fogliani, un viceré molto amato e poi deriso e maltrattato, costretto a lasciare Palermo per Messina, fu dovuta ad un malessere così esasperato che mise tanto subbuglio a Palermo e in tutta la Sicilia. Causa iniziale della protesta fu la gabella sulla luce, applicata su porte e finestre delle abitazioni. Ci fu una vera e propria guerriglia, alimentata anche dalla mancanza di grano e dalla morte del Principe del Cassero che molto fece per approvvigionare Palermo. Ma queste sommosse, di Palermo, Monreale e altri centri, finirono con tanto spargimento di sangue, con impiccagioni e galera di persone innocenti spesso sobillate dai capipopolo e poi da essi stessi accusati per avere salva la vita e continuare ad agire impuniti. Lo storico riporta uno stralcio del Villabianca, in cui asserisce che già allora era difficile scrivere e tramandare fatti criminosi, meglio tacere per dimenticarli. Siamo nel Settecento, ma la storia si ripete e lo stesso avviene tuttora. Commentando quella pagina, Messina così annota:
«Quante cose nella nostra storia non potranno mai essere chiare per questo, per la volontà di nasconderne gli aspetti non piacevoli e distruggerne anche il ricordo! e quante volte io stesso sono stato dissuaso dall’occuparmi di certi argomenti e personaggi, non solo dagli amministratori, dagl’intellettuali, ma da semplici e ignoranti individui e da persone che pure mi ripetevano che mi volevano bene! Io ho reagito sempre in un modo, intensificando le mie ricerche» (ib., p. 477).
Dalle pagine di questo volume emerge una Sicilia poco nota ai più. Bello decantarla con i colori della natura e delle opere d’ingegno collezionate nel corso dei secoli. Ma è triste, inumano costatare che nel secolo dei Lumi si consumavano delitti e misfatti atroci e crudeli. Si legga, ad es, il paragrafo dedicato al problema dei proietti, dei bambini neonati abbandonati ovunque, addirittura gettati in mare o uccisi. L’ignoranza e soprattutto la miseria la facevano da padrone. I governanti emanarono leggi per la regolarizzazione dei matrimoni, come era stato fatto nel passato anche più recente, e in diversi modi cercarono di risolvere il problema, ma erano ostacolati dagli amministratori di città e paesi che dicevano di non avere le risorse per mantenere i bambini, e molto spesso risultava vano ogni tentativo di soluzione.
Ciascuno cercava di curare il proprio orto e nessuno voleva cedere per migliorare e collaborare. Lo si nota anche a proposito dell’Inquisizione, quando il re avanzò ai suoi ministri la proposta di eliminarla. I Siciliani, senza esclusione di ceto, fecero di tutto per mantenerla e soltanto nel 1782 in Sicilia fu abolita. La motivazione era che tanti temevano di perdere il posto di lavoro, così anche l’esercito dei familiari, i moltissimi informatori disseminati dovunque, di cui fu garantita la segretazione dei nomi. Il nostro storico, a cui ogni occasione è buona per fare storia, narrando in prosa e in versi, trasferì questo dibattito nel già menzionato romanzo Volevano l’Inquisizione (1992), dove, a mo’ di dialogo, i personaggi rifanno la storia compresa in questo capitolo, fino al 1782, quando i popolani non riuscivano a capacitarsi come un istituto così importante, la Santa Inquisizione, potesse essere eliminato. Le voci di abolizione, giunte anche nei piccoli centri, facevano animatamente discorrere, come spesso avveniva, nelle botteghe e per le strade.
È interessante sapere che in questo periodo i Francesi erano attratti dalla Sicilia e avrebbero voluto allargare i loro commerci nei vari settori, ma erano ostacolati dai detentori del potere e si lamentavano che non erano trattati alla stregua degli altri stranieri nell’Isola. Per i loro rapporti con la Sicilia, rimando al libro, sempre di Messina, I viceconsoli di Francia in Sicilia (Paris 2001), da dove, a parte la successione dei vari viceconsoli e il loro operato, viene fuori un’immagine della Sicilia potenzialmente prospera, ricca di ogni bene di natura, ma ridotta alla fame per l’incuria e il malgoverno.
Lo storico, a leggere negli archivi di Parigi le tante relazioni periodiche dei viceconsoli al loro sovrano, prova un senso di sconforto e tanta amarezza dovuti ancora una volta alla staticità, a cui tuttora l’Isola sembra condannata ad essere. Eppure tra quei volumi trovò qualcosa di interessante, che a cercarla non l’avrebbe trovata, così come era capitato a tanti che l’avevano cercata. E ne gioì, perché fino ad allora di Cagliostro si conoscevano l’uomo e l’operato, ma incerta rimaneva la sua nazionalità, e per puro caso venne a conoscerla il nostro autore. Il Messina si trovò tra le mani la relazione con l’albero genealogico di Giuseppe Balsamo Cagliostro che l’avvocato della Francia in Sicilia, Antonio Bivona, aveva scritto e mandato il 12 marzo 1787. Una bella scoperta che mise fine ai dubbi su quel palermitano che tanto di sé faceva parlare in Francia e altrove. A questo punto il Nostro, da storico-narratore, si fa poeta e narra in versi le ultime ore di Cagliostro nella casa di rue Saint-Claude e l’arresto che nottetempo ne seguì. Questo racconto in versi, È ancora Cagliostro!, riportato anche in Di Gente in gente a Paris (2015), è una rievocazione («Cosa non facevano i parigini per lui! / Vedo nella via la loro fila / per essere ricevuti da lui / in barba ai philosophes / per toccarlo / per assistere alle sue magie / per chiedere i rimedi per le malattie / e di evocare pure le ombre / anche i diavoli / e lui tutti accontentava»), come se il dicitore si trovasse lì, in mezzo a tanto popolo che gridava e chiedeva la sua liberazione.
In questo lasso di tempo (1786) era viceré di Sicilia Caracciolo, molto vicino ai Francesi, per essere stato a lungo in Francia e per le nuove idee che vi circolavano, di cui si faceva portatore. Fu malvisto dai Siciliani, nonostante volesse apportare migliorie e modernità in fatto di costume; ma risulta evidente che poco o niente cambiava in Sicilia. C’erano uccisioni, e roghi, banditi e latrocini dovunque, miseria, e terremoti che aggravavano ancor più la situazione e quel che era peggio la carestia, che sofferenze e morti causò dovunque, come avvenne a Catania nel 1797/1798, oggetto de La carestia di Domenico Tempio, a cui Messina dedica tanto spazio, parafrasandola.
La venuta di re Ferdinando (25 dicembre 1798) in Sicilia chiude il capitolo e il volume. Vi trovò i tanti problemi irrisolti, congiure, liti e contrasti con gli stranieri, uccisioni di ogni sorta. Lo storico scrive:
«A questo punto non continueremo a narrare quello che avvenne nel 1799; ci fermiamo concludendo col ricordo di quegli accidenti che ancora ben rivelavano e rivelano il carattere persistente dei siciliani, il loro modo di reagire nei rapporti con gli esteri, con i turchi nel caso specifico, e di fronte a quello che proprio non potevano tollerare, come se nulla fosse cambiato in Sicilia» (ib. p. 553).
Così, con molta attitudine, Calogero Messina consegna a noi e a quelli che verranno un’immagine della Sicilia autentica e vera, quella che ancora meglio resiste nei paesi e nei piccoli centri, nonostante il modernismo dilagante e i continui bombardamenti dei media. Avrebbe potuto essere abbastanza più duro nei confronti di chi travisa la storia, ma non è nel suo stile; ha preferito aprirci ad una Sicilia dall’aspetto umano e al pullulare di interessi che danno vita alla storia.
Salvatore Vecchio
Da “Spiragli”, Nuova serie, anno III, nn. 1-2, 2023, pagg. 9-24.